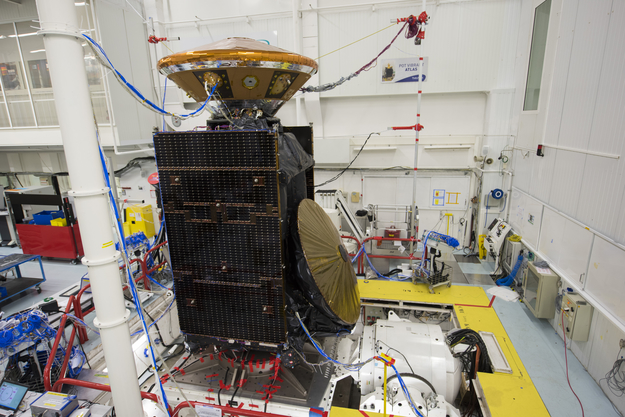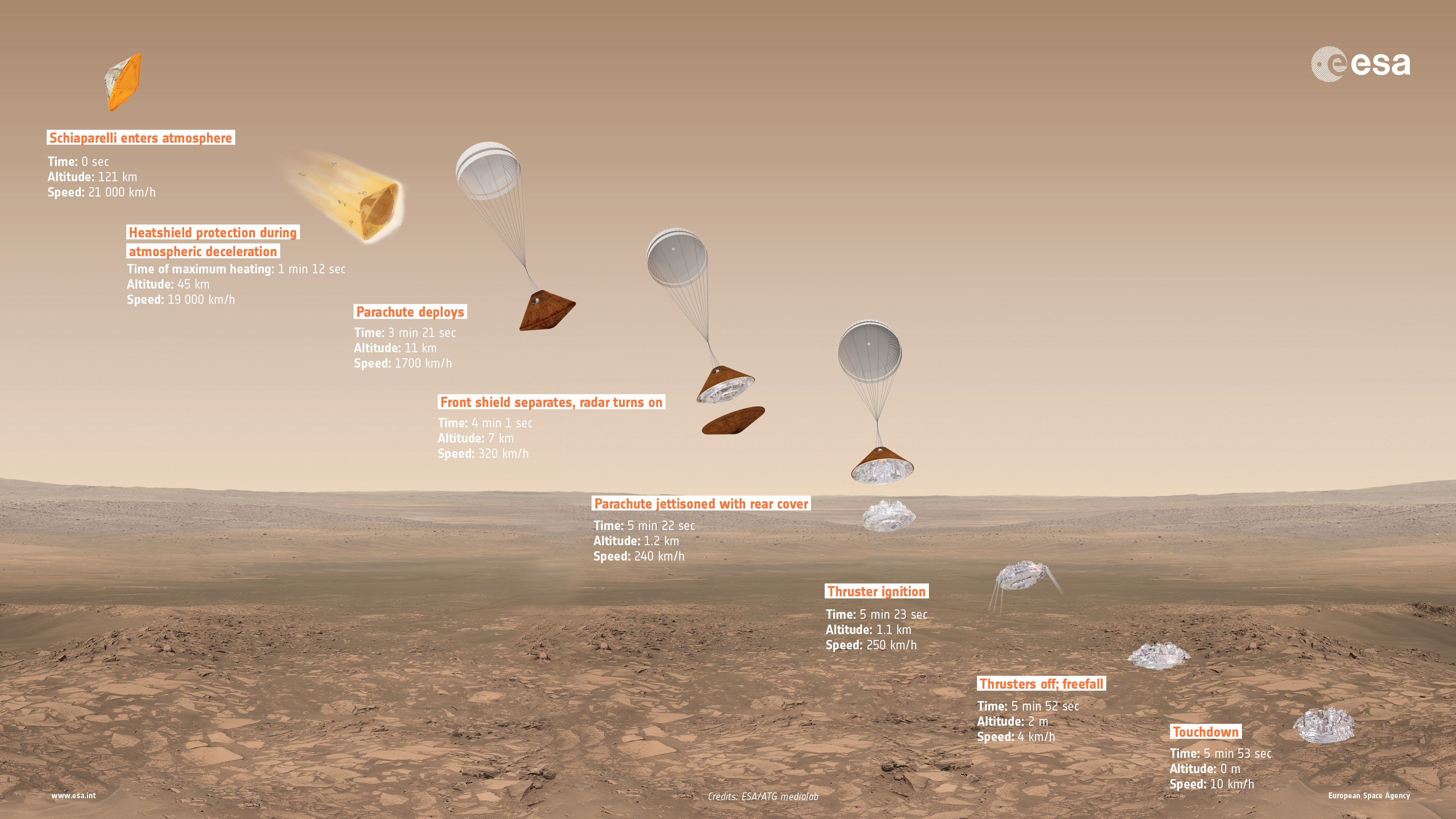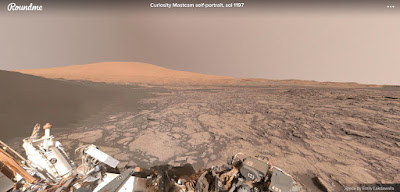Amo l’astronomia, l’astrofisica e naturalmente
l’esplorazione spaziale. Amo queste materie non come un adolescente può
prendere una cotta irrazionale per una ragazza ma, al contrario, è proprio
l’estrema razionalità che ho dentro a farmi amare ambiti in cui l’uomo mette
alla prova la sua conoscenza, la sua voglia di progredire e di risolvere
problemi, siano essi grandi come una galassia o piccoli come bere un bicchier
d’acqua. Amo la scienza, tutta, perché senza di essa, tutta, staremmo ancora a
cercare un modo per accendere un fuoco, per non far morire i nostri figli poco
dopo la nascita o per evitare malattie catastrofiche come morbillo, polio,
vaiolo, peste. Insomma, se ad accoglierci c’è il più bel presente della storia
degli esseri umani, con la prospettiva di un futuro migliore, non è un caso ma
il frutto indissolubile del progresso scientifico dell’uomo, della voglia e
della capacità, almeno per alcuni, di guardare oltre il dito che punta un
problema per cercare di risolverlo, in modi e tempi imprevedibili. È un
approccio che funziona, che ha sempre funzionato e che funzionerà, almeno
finché ci sarà qualcuno che sarà in grado di vedere al di là della propria
mano.
 |
| Rappresentazione artistica di TGO e Schiaparelli |
Spesso il lavoro di chi fa ricerca o di chi la divulga,
soprattutto nell’ambito astronomico e spaziale, è avvolto da un pesante velo di
indifferenza e ignoranza, un mix che ci consente di fare il nostro lavoro,
sebbene con un po’ di latente frustrazione, in tranquillità e al riparo dal
clamore mediatico che è in grado di creare sempre più problemi che soluzioni.
Spesso, ma non sempre: non avrei mai pensato che quelle poche volte che
astrofisici e ingegneri spaziali fossero venuti alla ribalta sarebbe stato per
subire un’onta peggiore della più assordante indifferenza.
Mi sono sentito in dovere di scrivere due parole, che poi
due non sono, ma spero che il tempo che ruberò alle vostre vite sarà stato
speso bene.
ExoMars è davvero un
fallimento?
A livello tecnico è inutile scaldarsi. L’ESA aveva già messo
in chiaro la questione da anni, non da giorni, come dice qualche commentatore
della domenica. La missione ExoMars prevedeva un orbiter, detto TGO, e una
piccola sonda da usare solo come test tecnologico per le fasi di atterraggio,
denominata Schiaparelli. La missione principale, di gran lunga più importante,
è quella di TGO, tanto che Schiaparelli non era stato dotato neanche di
pannelli solari: sarebbe quindi morto dopo qualche giorno sulla superficie di
Marte, una volta esaurite le sue batterie. Il piccolo lander
era così semplice a livello scientifico che non era neanche predisposto a
catturare immagini della superficie, visto che era dotato di una fotocamera in
bianco e nero che avrebbe dovuto riprendere solo le ultime fasi della discesa.
Insomma, a prescindere dalle opinioni, Schiaparelli era davvero solo un test,
quindi dire che tutta la missione è un fallimento rappresenta ormai una
consapevole bugia che sarebbe meglio smettere di raccontare. La sonda madre,
infatti, TGO, è in ottima forma e rappresenta una pietra miliare per
l’ambizioso piano di esplorazione dell’ESA dei prossimi anni.
E anche se lo fosse,
è la ricerca, baby
 |
| Le previste fasi di discesa di Schiaparelli |
Naturalmente se Schiaparelli si è schiantato, non tutto è
andato come doveva, anche se il suo apporto scientifico alla missione, sul
suolo di Marte, era quasi nullo. Quello che sappiamo è che i retrorazzi non
sembrano aver funzionato per il tempo previsto e che forse il paracadute non si
è aperto quando avrebbe dovuto. La chiarezza sulle delicate vicende dell’ultimo
minuto di vita del piccolo lander verrà alla luce nelle prossime settimane e
sarà ricca di dettagli e particolari, com’è giusto che sia. Quello che possiamo
dire al momento è che così funziona la ricerca. Quando ci si avventura in un
campo nuovo, gli errori non solo sono inevitabili ma fanno parte del gioco: che
ricerca sarebbe se andassimo a colpo sicuro e sapessimo esattamente cosa fare e
come farlo? L’esplorazione e la ricerca hanno in comune la conoscenza
dell’ignoto: se si sa già cosa ci aspetta, cosa può andare storto e come
affrontare ogni situazione non stiamo facendo ricerca ma qualcosa di già
conosciuto. Non è un caso che Schiaparelli fosse un test: si dovevano provare
le procedure e gli accorgimenti per fare qualcosa che all’ESA non hanno mai
fatto. È la ricerca, baby, che insegna anche qualcosa molto utile nella vita di
tutti i giorni: il fallimento è un modo per capire la strada da prendere, gli
errori da evitare, le correzioni da effettuare. È così che si impara, che ci si
evolve: può non piacerci ma così funziona tutto il mondo, persino la Natura (la
parola evoluzione non vi dice niente?).
Il
fallimento di Schiaparelli non è il primo e neanche l'ultimo: più della
metà delle missioni dirette verso Marte, sin dalla metà degli anni 60, è
fallita e solo gli americani sono riusciti a far atterrare qualcosa
sulla superficie sano e salvo. Si parla di maledizione marziana, ma la
realtà è che atterrare su Marte è molto complicato e richiede dei
sistemi di guida autonoma (vi dice qualcosa questo termine? Se ne parla
anche nella vita di tutti i giorni ormai) molto precisi e affidabili. E'
questo il gusto della sfida, la naturale attrazione per qualcosa di
quasi impossibile ma terribilmente affascinante, per un sogno che in un
primo momento sembra irrealizzabile ma poi, chissà, potrebbe funzionare.
E' un'attrazione che ci regala un perenne brivido lungo la schiena e ci
rende felici di essere vivi. Che gran peccato, invece, per chi non
riesce a emozionarsi per imprese di tale portata, perché manifesta una
triste aridità interiore.
Potere all’ignoranza
La storia del progresso umano è sempre stata trainata da un
gruppo di persone, che oggi chiamiamo ricercatori, esploratori o visionari,
limitatissimo rispetto alla popolazione mondiale, che con le proprie idee,
intuizioni e battaglie ha fatto progredire tutta l’umanità verso un benessere
che nella storia non ha mai conosciuto uguali. È normale quindi che tutta
l’umanità si regga su un manipolo di centinaia di migliaia, forse qualche
milione, di persone che dedicano la propria vita alla ricerca, alla scienza.
Perché, d’altra parte, è sicuro che senza scienza l’uomo non può progredire, in
alcun modo. Non stupiscono, quindi, certe critiche, quelle che si ricevono nel
peggior bar di Caracas tra uno shot di rum e l’altro: in un certo senso è una
manifestazione folkroristica dell’essere umano su cui ci si possono fare due
risate. Ma nel mondo attuale, globalizzato, unito dal comune rumore di fondo
dei social network che danno voce a tutti, con il medesimo diritto, e
dell’informazione che invade le nostre vite lasciandoci in pace solo quando
dormiamo, l’aspetto folkloristico si è trasformato in una pericolosa caccia
alle streghe, alimentata da un’immensa ignoranza
Un’ignoranza inconsapevole, distorta dalla realtà che si
sceglie di osservare, da rendere arroganti al punto di sentirsi in dovere di
esprimere un’opinione, spesso intrisa di odio e disprezzo verso quegli
“scienziati incompetenti”, loro che hanno studiato per anni quando bastava
frequentare l’università della vita, per capire come va il mondo. Un’opinione
che nella mente di molti risuona così importante e pomposa da reputare un
dovere il fatto di esprimerla, non più un mero diritto che spetterebbe alla
propria coscienza se rendere pubblico o meno.
Anche i miei nonni erano ignoranti, ma lo sapevano. Ecco
perché quando il dottore gli diceva di fare un vaccino, loro, senza capire come
funziona un vaccino e senza mettere in dubbio la sua efficacia, ascoltavano il
dottore perché: “Lui ci capisce, altrimenti non ci vado”. Oggi chi non capisce
come funziona una cosa è perché ha un’idea propria e distorta, della quale si è
innamorato come un tossicodipendente cronico della dose della mattina, che
sente in dovere di sbandierare a tutto il mondo, perché alla fine: “Io sono io
e voi non siete un cazzo!” è una frase che molti universitari della vita,
coloro che si informano su siti internet che parlano di scie chimiche e sbarchi
lunari farlocchi, pensano davvero.
Questo oceano in tempesta dell’esaltazione della propria
ignoranza, di una carenza di intelletto scambiata per indipendenza di pensiero,
ha travolto anche l’informazione generalista, almeno una consistente parte. Flotte
di analfabeti scientifici, tirati su orgogliosamente da un sistema scolastico
fallimentare, hanno il potere di divulgare le proprie idee su importanti mezzi
di informazione, senza conoscere affatto il campo di cui stanno parlando,
contribuendo a coltivare l’ignoranza arrogante di quelle che un noto critico
d’arte chiamerebbe capre, ripetendolo almeno tre volte.
Non viviamo nel
benessere per caso
Perché esplorare lo spazio? Perché andare su Marte con tutti
i problemi che abbiamo?
Queste due domande possono essere attaccate da almeno tre fronti:
uno prettamente logico, l’altro culturale e, infine, il terzo, pratico.
Dal punto di vista logico i problemi ci sono e ci saranno
sempre; se smettiamo di fare tutte le altre cose prima di risolverli, ci
estingueremmo. Perché comprare un telefono da centinaia di euro quando in
Africa ci sono bambini che muoiono di fame? Perché andare al ristorante quando
c’è gente che non ha un panino? Perché farsi una doccia al giorno quando in
Africa ci sono persone che muoiono di sete? Perché comprarsi vestiti quando
milioni di persone non se li possono permettere? Perché perdere tempo su Facebook
quando si potrebbe andare a fare beneficenza? Perché fare l’amore con il
proprio partner quando ogni giorno muoiono migliaia di bambini e si potrebbe
usare il tempo in cui cerchiamo di godere a fare del bene per gli altri?
Sono domande sensate o stupide? Anche se sotto ci potrebbe
essere, a volte, una sensibilità verso i problemi del mondo, il che è un bene,
le domande sono stupide perché è stupido il modo in cui si affronta la
questione, oltre che ipocrita. Qualcuno direbbe che sono tutti buoni samaritani
con il fondo schiena degli altri. È facile criticare una missione verso Marte
quando il 90% della nostra ricchezza viene sperperata in oggetti inutili, per
viziarci e ingrassare come maiali al punto da non riuscire più a muoverci,
vero?
Perché spendere soldi per vedere una partita di pallone, per
organizzare manifestazioni sportive, per andare a vedere un film al cinema e
ingozzarci di pop corn, quando nel mondo ci sono così tanti problemi e i soldi
servono per sfamare gli africani? Ecco, che sensazione si prova quando demagogia
e populismo si basano su fatti reali che mostrano la vostra superficialità e
ipocrisia?
Dal punto di vista culturale, la ricerca, qualunque sia, compresa
l’esplorazione dello spazio, è ciò che ci differenzia dalle scimmie, con
rispetto parlando per loro; è un ottimo indicatore della ricchezza culturale di
una società e dei suoi abitanti. E se in Italia le cose non vanno bene, con
decine di migliaia di giovani laureati costretti a emigrare per ottenere un
minimo di dignità, il motivo è che non si fa abbastanza ricerca. Questo è un
Paese vecchio, ma non solo anagraficamente. È un Paese vecchio di idee, che si
è arricchito senza migliorare il proprio livello culturale, con il risultato che il misero e umile contadino, come lo era mio nonno, si è trasformato in un
bifolco arricchito e viziato, con l’idiota convinzione di essere acculturato,
di avere dovere di opinione su tutto, pur non sapendo un cazzo. Un Paese di bifolchi
travolto da un immeritato benessere economico e che ora si sente così potente
da millantare verità su stupide scie chimiche o sui vaccini che causano l’autismo.
Gli scienziati veri? Gente che non capisce nulla, nella migliore delle ipotesi.
Dei patetici corrotti, al soldo dei potenti, nei casi più gravi.
Fare ricerca, fare scienza,
spendere soldi per scoprire chi siamo, da dove veniamo e dove possiamo
arrivare, risponde alla nostra voglia ancestrale di conoscere e di esplorare; è
ciò che ha guidato la nostra intera evoluzione. Se ci fossimo fermati non
saremmo qui a scrivere e a leggere su uno schermo di un dispositivo che sta nel
palmo della nostra mano. Si potrebbe dire, allora, sotto questo punto di vista:
a cosa serve la musica, la letteratura, l’arte, la pittura?
Il terzo punto è prettamente
pratico. In fin dei conti le capre se ne infischiano della cultura, degli
ideali di progresso ed esplorazione: sono contente di pasturare sempre nello
stesso campo, senza mai guardare in alto per chiedersi chi sono e cosa ci fanno
lì. Basta dar loro da bere, mangiare e qualche sedativo tecnologico per sprecare
il proprio tempo senza dover pensare davvero al prossimo e ai problemi del
mondo. La ricerca, anche spaziale, al contrario dell’abbuffata superflua di
sushi del sabato sera (quanti bambini si potevano sfamare con tutto quel cibo??),
ha un impatto incredibile sulle nostre vite. Se oggi stiamo bene, come ho già
detto, non è un caso. Gran parte della nostra tecnologia e del nostro benessere
derivano direttamente o indirettamente da pionieristici studi aerospaziali.
Quelle sonde inutili mandate su Marte, sin dagli anni 60, hanno testato
materiali e tecnologie che ora noi usiamo tutti i giorni e delle quali non
possiamo più fare a meno. Tecnologie e soluzioni che possono risolvere anche i
problemi di questo mondo, come fame e sete, se solo la politica, quindi il
popolo sovrano, lo volesse davvero. La verità, cari leoni da tastiera, è che
siete voi, con la vostra egoistica, miope e sommamente ignorante visione del
mondo a impedire che i problemi grossi di questa Terra vengano risolti, a mantenere ancora la fame nel mondo, a gioire nel soffocare sommersi dai gas di
scarico, a negare lavoro e futuro ai vostri figli. Siete voi a
comandare, purtroppo, e a decidere il futuro del mondo. Volete un esempio?
Pensate all’emergenza dei migranti e a come vorreste risolvere il problema di
questi disperati, purché se ne restino a casa loro e non minaccino il nostro
stile di vita: ipocriti!
Tutta la ricerca
scientifico/tecnologica atta a superare i propri limiti obbedisce a una regola
molto potente: non importa cosa si cerca, quale sia l’obiettivo del proprio
sforzo tecnologico; nel lungo cammino compiuto per raggiungerlo, si conquistano
decine di altri traguardi che possono rivelarsi estremamente utili per molti
altri scopi.
Le ricadute tecnologiche
dell’esplorazione spaziale sono così tante che sarebbero richieste decine di
pagine solamente per stilare uno sterile elenco. Non voglio proporre una
sterile lista, ma far capire meglio in che modo una sonda nello spazio aiuti a
migliorare le nostre vite molto di più di quanto si possa immaginare, perché è
facile criticare di fronte a un computer, magari alimentato a pannelli solari,
pubblicando fotografie scattate con un cellulare mentre si guardano le mappe
satellitari in alta risoluzione.
Da dove provengono tutte queste
tecnologie?
Con il termine inglese spin-off
si identificano tutte quelle tecnologie sviluppate per
l’esplorazione spaziale che sono state poi adattate per essere
utilizzate nella vita di tutti i giorni.
Tra le più importanti degli
ultimi anni c’è sicuramente il tema dell’energia fotovoltaica.
La tecnologia dei pannelli solari
è stata utilizzata fin dalle prime missioni spaziali automatiche, tranne nei
casi in cui le sonde erano dirette verso le regioni esterne del Sistema Solare.
L’agenzia russa e soprattutto
americana hanno effettuato importantissimi studi nel disporre di una tecnologia
leggera, affidabile e sempre più efficiente dal punto di vista energetico.
I pannelli solari che abbiamo sul
nostro tetto derivano direttamente da questi pioneristici studi; senza le sonde
interplanetarie, probabilmente questa tecnologia sarebbe arrivata solamente tra
molti anni.
Molto importante anche il campo informatico,
dove il contributo della NASA è stato fondamentale.
Negli anni 60 con l’inizio del
programma Apollo una grande quantità di energie fu destinata alla creazione di
computer abbastanza piccoli da essere contenuti nel modulo di comando e
sufficientemente potenti da pilotare l’astronave durante il viaggio verso la
Luna.
Il grande sviluppo informatico,
necessario per ricerca spaziale, è stato determinante per la rivoluzione
informatica di massa iniziata sul finire degli anni 80.
I moderni programmi di
navigazione spaziale a bordo di ogni satellite, dai GPS che guidano le nostre
auto, a quelli che consentono di guardare la televisione, derivano dagli studi
intensi condotti a partire dagli anni 60.
Anche nel campo medico le
ricadute sono molte: dai termometri a infrarossi sviluppati per primi nelle
sonde automatiche, ai nuovi materiali utilizzati per le protesi artificiali
derivati direttamente dagli studi della NASA, allo sviluppo della tecnologia a
diodi per la cura di alcune lesioni.
I sistemi di controllo remoto,
gli stessi che consentono di attivare un allarme o un elettrodomestico con
l’uso di un semplice cellulare, derivano dalla tecnologia sviluppata per il
controllo di sonde a milioni di chilometri di distanza e dei rover
radiocomandati su Marte.
Le fotocamere digitali che hanno
reso accessibile la fotografia a chiunque e che ormai equipaggiano addirittura
tutti i telefoni cellulari derivano da intensi studi e ricerche per
l’efficiente ripresa e trasmissione delle immagini provenienti dalle sonde
automatiche.
Le conoscenze tecnologiche
accumulate e poi rese pubbliche hanno dato inizio all’inevitabile era della
fotografia digitale.
I moderni pneumatici che
consentono maggiore aderenza e sicurezza derivano dalle ricerche cominciate durante l’esplorazione lunare
sulle mescole da utilizzare per le ruote della Jeep che è stata utilizzata
dagli astronauti di Apollo 15-16-17 durante la loro missione.
Il materiale ignifugo dei vigili
del fuoco deriva dallo studio sulla costruzione delle prime tute spaziali per
le passeggiate degli astronauti.
Hanno fatto molto di più dei
miseri ingegneri aerospaziali per risolvere la fame del mondo che tutti gli
ipocriti leoni da tastiera che regalano perle di ignoranza, di cui nessuno
sentiva la mancanza. La vera domanda è: ci meritiamo tutto questo benessere? È
giusto, a questo punto, che poche migliaia di persone che fanno ricerca,
rendano disponibili risultati e scoperte a un mondo che in gran parte non solo
non capisce quello che stanno facendo, ma vorrebbe rabbiosamente rinunciare a
tutto questo?
Un costo irrisorio per un progresso eccezionale
Come se non bastasse, c’è un mito
da sfatare: le missioni spaziali costano troppo, meglio dirigere i soldi su
altri problemi. Questa è una balla colossale: gli sprechi sono altri. Il denaro
speso per le missioni spaziali è il modo più efficiente per dare lavoro e una
carriera a gente qualificata e preparata, a quella folta schiera di ragazzi
sognatori e laureati che ogni anno devono espatriare per vedersi riconoscere un
minimo di dignità alle loro vite. Fare ricerca, anche spaziale, è l’unico modo
che conosciamo per vincere i limiti imposti da questo pianeta e sperare di
risolvere, osservando ed esplorando lo spazio, anche i problemi economici e
sociali attuali e futuri. O davvero speriamo di poter capire come generare
energia rinnovabile e a basso impatto ambientale restando chiusi in casa a
osservare una lampadina spenta, evitando persino di uscire, perché bisogna
risolvere questo problema? Davvero pensate che il mondo vada in questo modo?
Che per riuscire a conficcare un chiodo nel muro basti osservare il muro e il
chiodo per sufficiente tempo e non andare neanche in ferramenta a comprare un
martello?
I 15
miliardi di dollari destinati alla NASA attualmente ogni anno dal governo degli
Stati Uniti, possono sembrare tantissimi, ma rappresentano circa lo 0,2% del
prodotto interno lordo del paese.
Tagliare
i costi dell’esplorazione spaziale per risparmiare il 2 per mille del denaro
dei contribuenti, di certo non può in alcun modo aiutare il benessere della
comunità o rimettere ordine nel bilancio statale.
Se
questo comunque non dovesse ancora convincere i più scettici, facciamo un
paragone con altre spese, alcune di dubbia utilità, per vedere quale sia il
peso relativo dell’esplorazione spaziale nell’economia di un paese.
Il
termine di paragone più impressionante riguarda i costi di una guerra.
L’impegno
militare in Afghanistan prima e in Iraq poi del solo governo americano
ha richiesto una
spesa
superiore a 3000 miliardi di dollari(!) in circa 10 anni, vale a dire circa
300 miliardi di dollari l’anno. Un paragone con il programma Apollo, costato 20
volte di meno, mostra che con questo denaro si potevano lanciare sulla Luna
almeno 7 astronavi l’anno per 10 anni e dare lavoro a centinaia di migliaia di
ingegneri, fisici, astronomi, operai, unire l’umanità invece di dividerla,
risparmiare molte vite umane e portare benessere in tutto il pianeta con le
ricadute tecnologiche di un programma così ambizioso.
Un confronto con il programma
Shuttle è ancora più impietoso: il denaro speso in 10 anni di guerra poteva
finanziare una missione al giorno per tutto questo periodo di tempo.
Anche nel nostro piccolo paese
non mancano i paragoni a effetto.
Si pensa che l’Italia sia una
nazione troppo piccola per un programma spaziale?
No, è semplicemente uno dei tanti
stati che considera prioritarie altre spese, che però non vengono comunicate ai
contribuenti, come i famosi caccia vari governi si sono impegnati ad acquistare
nei prossimi anni, per un totale di circa 15-18 miliardi di euro di spese
militari in un periodo (fortunatamente) di pace.
La missione Pathfinder, che ha
portato su Marte il primo rover ha avuto un costo totale di 280 milioni di
dollari, circa 220 milioni di euro, minore del prezzo di due di questi jet.
Con il denaro speso l’Italia avrebbe potuto mandare su Marte circa 50
rover.
Dieci euro per cinquanta milioni di italiani sarebbero sufficienti per
lanciare una sonda verso Marte. Vogliamo provare a immaginare le ricadute
sull’economia, l’industria e il nostro benessere a fronte di questo minuscolo
investimento?
Migliaia di nuovi posti di lavoro, il rientro dei nostri giovani migliori
costretti a emigrare per realizzare i propri sogni, il richiamo dei grandi
investitori esteri e l’instaurarsi di un’economia tecnologica che farebbe
diventare il nostro paese ai primi livelli nel mondo.
Pochi miliardi di euro nella giusta direzione sarebbero trasformati in un
investimento che potrebbe fruttare oltre 10 volte tanto in meno di dieci anni,
se consideriamo il lato puramente economico.
Tutto questo in uno scenario in cui dovessimo fare tutto da soli. Nella
realtà l’Italia fa parte dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e i costi sono
quindi da dividere per 22 paesi partecipanti e centinaia di milioni di persone.
Ecco allora che una missione complicata come Rosetta, i cui costi sono simili a
quelli dell'intero programma ExoMars (missioni del 2016 e del 2020), è costata ai cittadini europei circa 3 euro e mezzo in 19 anni: 20
centesimi l’anno. Ma quando apriamo la bocca dicendo che le missioni spaziali
costano troppo, abbiamo una minima idea di quello che stiamo dicendo?

Alla fine di questo lungo post, ripetiamo allora insieme la
domanda per eccellenza: perché andare su Marte quando qui c’è gente che muore
di fame? Perché stiamo facendo più noi scienziati spedendo una lavatrice su un
pianeta deserto, per tutti voi, che chiunque mentalmente limitato e comodamente
seduto sul proprio divano abbia il coraggio di porsi una domanda del genere, senza
che un brivido di vergogna attraversi il suo corpo. La domanda giusta è,
ancora una volta: ce lo meritiamo tutto il progresso e la ricerca che sta portando
avanti un pugno di uomini sognatori per tutta l’umanità, quando questa ha una
visione tanto distorta e differente della realtà e del futuro?