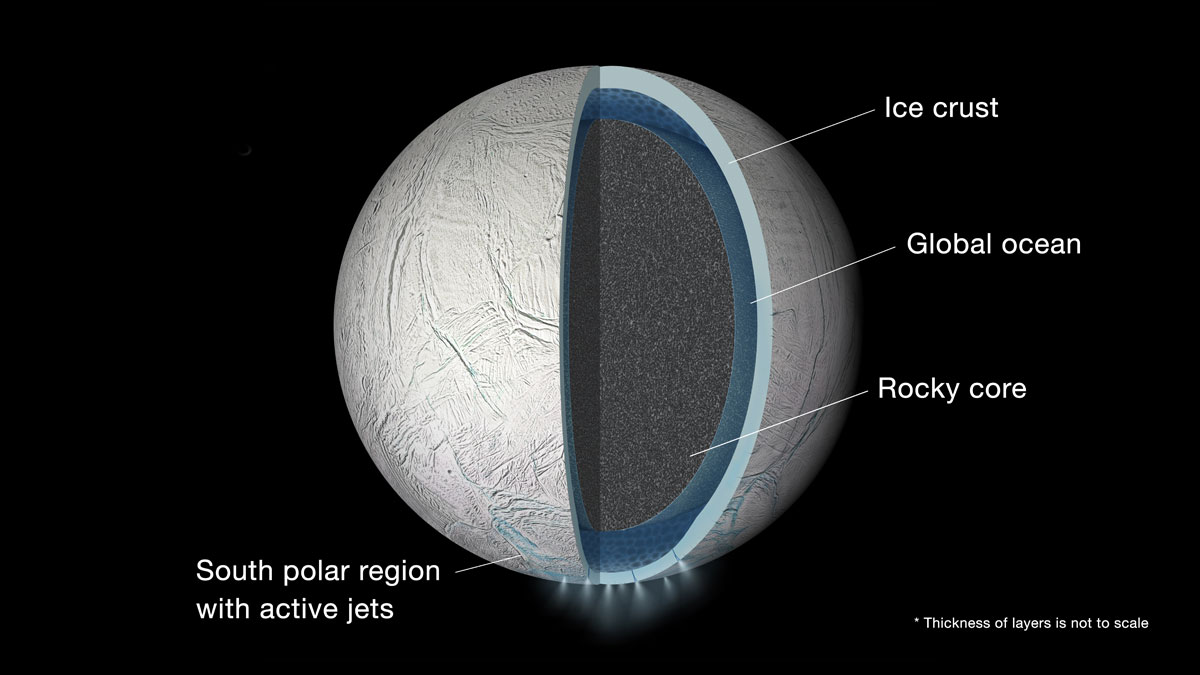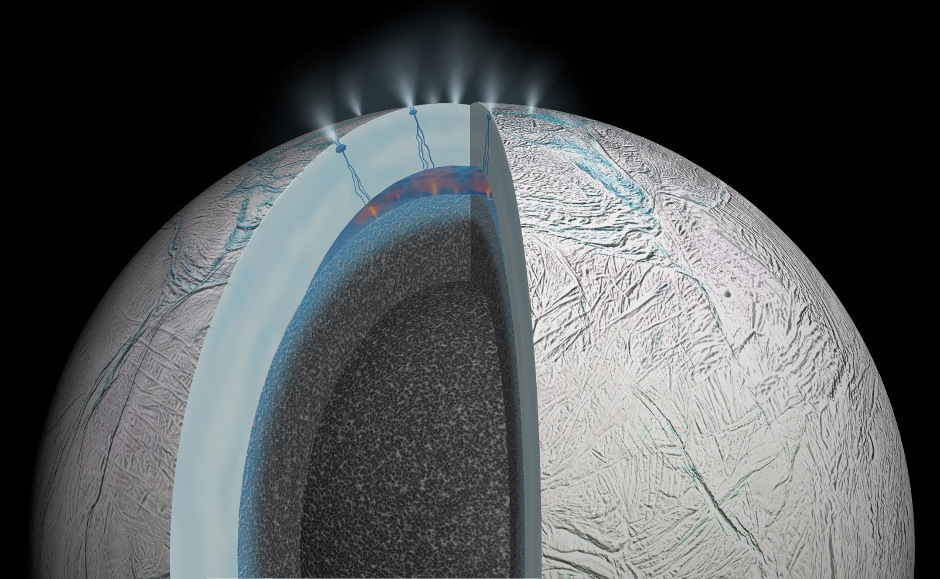Questo post è tratto dal mio libro "Sognando il Sistema Solare", disponibile in ebook Kindle, in PDF ad alta risoluzione e in versione cartacea con il nuovo titolo di "Conoscere, Capire, Esplorare il Sistema Solare"
C'era acqua nel passato di Marte?
Il
mistero più affascinante di Marte ruota attorno alla presenza o meno di acqua
nel suo passato e nel presente.
 |
Fiume su Marte?
|
I dati
ricevuti dalle prime sonde giunte sul pianeta, tra cui le gloriose Viking,
hanno sollevato un problema di cui ancora se ne discute animatamente a distanza
di oltre 30 anni.
Le
immagini provenienti dalla superficie e dall’orbita hanno fornito numerosi
indizi sul fatto che il pianeta un tempo fosse estremamente diverso dall’arido
deserto attuale.
Oltre
alle peculiari proprietà dell’emisfero nord, che potrebbero essere spiegabili
anche con un gigantesco impatto che avrebbe rimodellato la superficie, nel
dettaglio il suolo marziano è percorso da quelli che sembrano resti di decine
di fiumi e grandi laghi, come quello riportato nell’immagine a destra.
Se
infatti confrontiamo queste immagini con le situazioni familiari e più conosciute
della Terra, gli indizi potrebbero addirittura trasformarsi in prove evidenti.
Un fiume
che scorre per lungo tempo nel suo letto modella la superficie, leviga le
pietre, scava il terreno, muove la sabbia, genera valli e canyon. Molte sono le
formazioni di questo tipo scoperte dalle sonde in orbita.
Il fatto
che attualmente non vi sia acqua in questi probabili antichi letti, alcuni dei
quali davvero giganteschi, è ciò che impedisce agli scienziati di essere certi
della loro origine.
Perché
così tanta incertezza?
Sostanzialmente
perché la nostra analisi si basa solamente su una somiglianza visiva con le
strutture geologiche che sulla Terra sono formate dallo scorrere dell’acqua.
Siamo proprio sicuri, però, che non potrebbero esserci altri motivi, che attualmente
ignoriamo, per cui su Marte si siano formate strutture simili senza dover per
forza di cose considerare l’azione erosiva prodotta dal nostro familiare
liquido trasparente?
La
prudenza resta d’obbligo anche guardando un’immagine apparentemente eloquente
come quella sopra, per un motivo molto semplice: le
condizioni di pressione e temperatura sul suolo marziano attualmente impediscono
all’acqua pura di esistere stabile allo stato liquido.
Presso i
poli è congelata, alle basse latitudini può esserci solo sottoforma di vapore.
Ammettere
che quelle strutture siano letti di antichi fiumi, significa quindi rendere
implicito che un tempo l’atmosfera del pianeta rosso fosse profondamente
diversa, tanto da consentire all’acqua di scorrere liberamente e in grandi
quantità.
Uno
scenario del genere solleva, proprio come gli imponenti venti marziani, molte
altre domande: come si è modificata l’atmosfera? Perché è cambiata così tanto?
E dove è finita tutta l’acqua?
Difficile
ancora mettere insieme i pezzi di un puzzle davvero estremamente più complicato
di quanto si potesse pensare, anche perché molte delle analisi necessarie per
confermare o confutare la teoria devono essere fatte sul luogo.
Fino a
questo momento sono stati trovati degli indizi, alcuni a dire la verità davvero
forti.
Il rover
Opportunity ha trovato rocce sedimentarie, che sulla Terra si formano solamente
in presenza di acqua.
 |
| Ghiaccio d'acqua su Marte |
La sonda
Phoenix ha confermato che alle alte latitudini il terreno è pieno di ghiaccio
d’acqua.
Lo strato
di permafrost, così viene chiamato il suolo perennemente ghiacciato, potrebbe
contenere una riserva grandissima di acqua, tale da ricoprire buona parte
dell’emisfero nord del pianeta se diventasse liquida.
Le
osservazioni delle sonde in orbita attorno al pianeta, in particolare quelle di
Mars Odyssey, hanno mostrato che senza la protezione del campo magnetico,
l’atmosfera del pianeta rosso si sta lentamente disperdendo nello spazio a
causa dell’azione erosiva del vento solare.
Questa
osservazione è fondamentale, perché se riuscissimo a campire il ritmo con cui
l’atmosfera evapora e la sua eventuale stabilità nel tempo, potremmo dare forza
alla teoria secondo cui l’antico inviluppo atmosferico del pianeta fosse molto
diverso da quello attuale. Se l’atmosfera era più spessa e calda, le grandi
quantità d’acqua che ora si trovano nel sottosuolo potevano formare laghi e oceani
in superficie.
Acqua nel presente di Marte?
Le
indagini condotte dalle sonde, come appena visto, non sono in grado di dirci
ancora se nel passato di Marte ci fosse con certezza acqua liquida, ma possono
sicuramente aiutarci a comprendere se nel presente questo importante liquido
possa ancora scorrere.
Se fino a
qualche decennio fa gli scienziati erano convinti che le condizioni di Marte
impedissero categoricamente l’esistenza di acqua liquida, le osservazioni più
dettagliate dell’intera superficie planetaria degli ultimi anni hanno in parte scalfito
queste convinzioni, a dimostrare che non bisogna dare mai nulla per scontato
nella scienza!
A
cominciare dalla sonda Mars Globar Surveyor, la prima che dall’orbita aveva la
strumentazione per riprese in alta risoluzione, sulla superficie del pianeta
rosso si sono cominciati a osservare dei piccoli canali da scolo lungo le
ripide pareti di crateri o di alcune scarpate.
In poco
più di dieci anni il loro numero è salito ad alcune centinaia.
Gli
scienziati inizialmente pensavano si trattasse di antichi canali da scolo
simili ai grandi letti di fiumi precedentemente osservati sulla superficie,
sicuri del fatto che l’acqua liquida non potesse scorrere su Marte. Ben presto,
però, Mars Global Surveyor riprese delle immagini che spiazzarono i planetologi
di tutto il mondo e riaccesero le speranze sulla possibile esistenza di acqua
liquida.
Le
immagini riprese a distanza di pochi anni mostravano sensibili cambiamenti
nella forma e nel materiale contenuto nei canali. Questo era un chiaro indizio che
il fenomeno alla base della loro creazione fosse ancora attivo.
 |
| Cosa sono i gully? |
Negli
anni successivi le sonde dell’ultima generazione, tra cui l’europea Mars
Express e l’americana Mars Reconneaissance Orbiter, hanno ripreso centinaia di
altri canali, in inglese denominati gully.
Se alcuni
gully sembrano attivi, potrebbero essere causati dallo scorrere di acqua che si
trova imprigionata nel sottosuolo e che a volte trova una via d’uscita sulla superficie?
Di nuovo,
se fossero stati osservati sulla Terra non avremmo avuto alcun dubbio. Ma è
bene ricordarsi che stiamo osservando fenomeni su un altro pianeta sensibilmente
diverso dal nostro, per cui lasciarsi trasportare da una facile somiglianza potrebbe
essere il modo migliore per cadere in inganno.
C’è poi
un problema che non possiamo di certo trascurare: l’acqua liquida sulla
superficie di Marte avrebbe vita estremamente breve. Se potessimo aprire una bottiglia
sul suolo marziano, questa esploderebbe violentemente perché il liquido inizierebbe
a bollire in modo estremamente vigoroso, evaporando completamente in pochi
secondi.
La
situazione è simile a quando si getta acqua su una padella rovente usata per la
frittura.
Se dovessimo
trovarci in prossimità delle regioni polari, invece, la bottiglia congelerebbe
quasi istantaneamente.
Se il
liquido che crea i gully fosse acqua pura, non potrebbe mai percorrere le
centinaia di metri di lunghezza dei canali alle latitudini cui sono stati
osservati.
Ma allora,
di quale liquido potrebbe trattarsi? E siamo proprio sicuri che debba trattarsi
di liquido?
Nel 2009
gli scienziati dell’università dell’Arkansans hanno condotto una serie di
esperimenti in laboratorio per comprendere se la sostanza che alimenta i gully
possa essere composta da una miscela di acqua e sali.
Dopo
molti tentativi è stata trovata la soluzione, semplice quanto efficace: il
liquido misterioso potrebbe essere una specie di salamoia.
I sali
disciolti nell’acqua ne alterano sensibilmente il punto di solidificazione; con
la giusta concentrazione possono permetterle di esistere liquida anche nelle
particolari condizioni marziane, sia pur per brevi periodi di tempo.
La
salamoia non è stata generata con il classico sale da cucina ma con uno la cui
presenza è stata rilevata in abbondanza sulla superficie di Marte: il solfato
di ferro.
Quando
l’acqua è mischiata alla giusta quantità di solfato di ferro può solidificare a
ben -68°C sulla superficie di Marte, una temperatura compatibile con quelle registrate
durante il giorno nelle zone interessate dal fenomeno.
Questo
proposto, però, è solo un modello che cerca di replicare le osservazioni sulla
distribuzione dei gully e sulle proprietà dell’atmosfera marziana, ma è ancora
lunghi dall’essere provato. Esso, in effetti, parte dal principio secondo cui i
canali siano generati necessariamente da un liquido. Se così fosse, non può che
trattarsi di una soluzione di acqua e sali.
 |
| Una possibile spiegazione per i gully |
Una
dettagliata analisi delle immagini riprese dalle più recenti sonde automatiche
in orbita attorno al pianeta rosso, ha però seriamente messo in dubbio questo
modello.
Ci sono
molte domande alle quali non si trova una risposta convincente: perché l’acqua
dovrebbe scorrere alle medie e alte latitudini, laddove si concentra la grande
maggioranza dei gully, e non nelle più temperate zone equatoriali?
Com’è
possibile che l’attività dei canali si manifesti solamente durante o al termine
della stagione invernale, quando la temperatura è più bassa?
La forma
dei nuovi canali è compatibile con lo scorrere di un liquido nelle condizioni
marziane?
Recenti
simulazioni al computer hanno dimostrato, purtroppo, che i gully, almeno quelli
recenti e ad alte latitudini, sono probabilmente generati dal rotolamento di
detriti in condizioni asciutte. La teoria attualmente più accreditata prevede
un ruolo centrale del ghiaccio secco. Durante gli inverni si deposita in
discrete quantità al suolo. In prossimità di pareti ripide può generare
valanghe che trascinano a valle i detriti e creano i gully. È inoltre
plausibile che sul finire dell’inverno il ghiaccio accumulato cominci a
sublimare in conseguenza dell’aumento delle temperature, generando sbuffi di
gas che producono piccoli smottamenti.
Certamente
un duro colpo per tutti coloro che speravano nell’esistenza di acqua liquida
sul pianeta rosso.
 |
| Acqua recente su Marte? |
Non tutto
comunque è perduto. Alcune immagini acquisite a latitudini minori mostrano
un’altra famiglia di gully, la cui forma questa volta è compatibile con lo scorrere
di acqua liquida in tempi geologicamente recenti. E questo, purtroppo,
significa che l’acqua che ha generato questa seconda classe di canali sgorgava
probabilmente circa un milione di anni fa.
È un po’ frustrante
e sconfortante pensare che basterebbe un’unica spedizione umana per risolvere
questo e tanti altri misteri legati al pianeta rosso. Un astronauta che dovesse
giungere nei pressi di un gully potrebbe raccogliere il terreno e analizzarlo,
scoprendo in questo modo l’età e l’origine di questi misteriosi dettagli.
Tutto
questo, però, al momento non è nient’altro che un sogno irrealizzabile.
Dovremo
continuare ad affidarci ai piccoli robot automatici per cercare di completare l’intricato
puzzle sul pianeta più simile alla Terra che attualmente conosciamo in tutto
l’Universo.